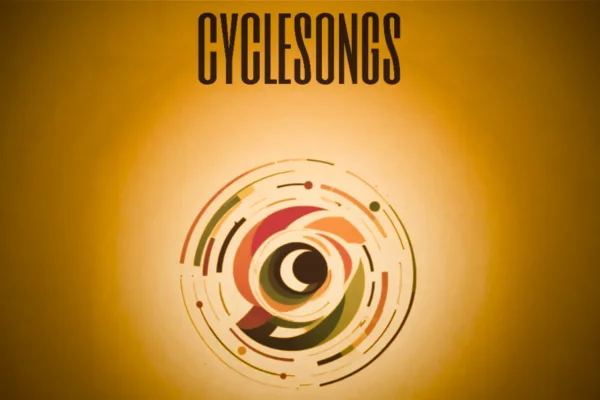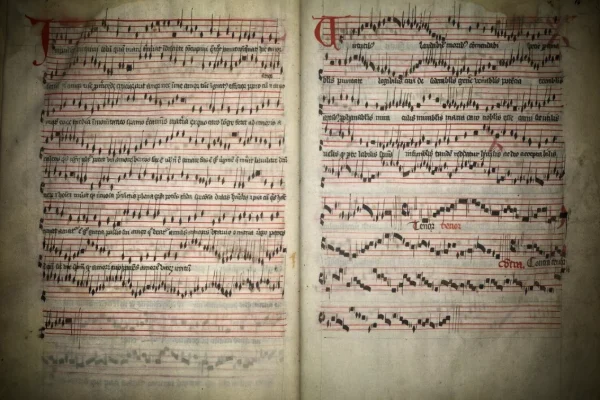INDICE ARTICOLO
Il Suono come Fondamento Identitario del Cile
Il Canto Cileno non è una singola tradizione monolitica, ma una stratificazione complessa di espressioni culturali che rispecchiano i profondi cambiamenti storici, sociali e geografici della nazione. L’indagine sulla sua storia e sui suoi stili abbraccia un arco temporale “millenario”, che si estende dalle pratiche rituali pre-ispaniche alle sofisticate fusioni urbane del XXI secolo. Questo articolo adotta una prospettiva etnomusicologica olistica per analizzare questa evoluzione, considerando la musica nel suo contesto culturale, integrando discipline come l’antropologia, il folclore e la storia, un approccio necessario per superare le narrazioni eurocentriche tradizionali.
Premesse Metodologiche: La Ricerca Globale e l’Approccio Olistico
L’approccio etnomusicologico consente di investigare non solo le strutture musicali, ma anche le pratiche sociali, le narrazioni storiche e il significato della musica nelle diverse culture. In Cile, questo è cruciale data la sua storia di colonizzazione e immigrazione. Il Cile, come striscia di terra compressa tra le Ande e l’Oceano, ha visto la fusione di culture indigene (principalmente Mapuche e Aymara), spagnole, africane e successivi flussi migratori europei. La musica cilena è stata plasmata da cinque periodi chiave: il periodo Pre-Ispanico; l’era Coloniale e il Sincretismo; il Folclore; la Nueva Canción Chilena (NCCh); e la musica Contemporanea.
Il Cile come Mosaico Geografico e Sonoro: Dalle Ande alla Patagonia
La geografia cilena prefigura la sua diversità sonora. Il Paese, con i suoi deserti settentrionali, le valli centrali e le isole meridionali, ha sviluppato tradizioni regionali distinte. Sebbene la società agraria coloniale si concentrasse nel Cile centrale, i contributi sonori provenivano da tutte le estremità del territorio. Il nord ha mantenuto forti legami con la cultura andina (Altiplano), il centro ha sviluppato l’alta arte del Canto a lo poeta, e il sud, in particolare l’arcipelago di Chiloé, ha assorbito influenze germaniche e sviluppato una musica caratterizzata da un ritmo agile e vitale, come la Pericona.
Le Radici del Suono Millenario: Cosmologia e Canto Indigeno
La tradizione musicale cilena affonda le sue radici più antiche nelle pratiche sonore dei popoli indigeni, in particolare i Mapuche (Araucani), che costituiscono il gruppo autoctono più numeroso in Cile e Argentina.
Il Concetto di Newen e la Funzione Rituale Mapuche
La musica Mapuche è inseparabile dal loro sistema cosmologico. Il concetto fondamentale che sottende il suono Mapuche è il newen, definito come la forza immanente di tutto il mondo. Nella concezione Mapuche, il suono trascende la mera forza vibratoria: esso è una manifestazione del newen stesso.
Questa doppia comprensione del suono come fenomeno fisico e come manifestazione ontologica si allinea con le teorie etnomusicologiche contemporanee sull’affetto e la materialità del suono.
Il rituale di guarigione noto come Ulutun, guidato da una machi (sciamana), impiega preghiere e canti per rivitalizzare la persona e l’ambiente, con il potere di questo suono percepito come emanazione diretta del newen.
Il Kultrún, Trutruka e la Musica Cerimoniale
Gli strumenti Mapuche sono intrinsecamente legati alla funzione rituale e alla divisione di genere. I principali sono il kultrún, un tamburo cerimoniale suonato specificamente dalle machi, e la trutruka, una lunga tromba realizzata in bambù, riservata agli uomini per gli eventi cerimoniali. La persistenza del canto Mapuche come manifestazione del newen si pone in netto contrasto con la musica sacra importata dai colonizzatori, che veicolava un sistema teologico trascendente, rappresentando una profonda contestazione ontologica del significato stesso del suono.
Il Periodo Coloniale e la Genesi del Sincretismo
La colonizzazione spagnola, iniziata nel 1540, configurò una società dove la musica divenne un potente strumento di evangelizzazione e, simultaneamente, un catalizzatore per nuove forme sincretiche.
L’Impronta Ispanica: Dal Canto Gregoriano al Villancico Barocco in Cile.
A livello popolare e religioso, l’insegnamento del canto cattolico lasciò un’impronta duratura, influenzando i repertori folcloristici ispano-americani con l’uso dei modi ecclesiastici e l’approccio melodico tipico del canto gregoriano.
Un esempio centrale di sincretismo religioso e culturale è il villancico barocco.
I villancicos cileni operavano come sonorizzazioni di una messa in scena, permettendo l’introduzione di elementi estranei alla pura narrativa biblica e localizzando stili europei all’interno del contesto di Santiago.
Il Contributo Afro-Cileno: tracce ritmiche e il ruolo nella formazione di danze nazionali.
Un elemento costitutivo, benché per lungo tempo negato, della musica criolla cilena è il contributo della diaspora africana. Nonostante la negazione statale (il governo ha riconosciuto ufficialmente la presenza storica afro-cilena solo nel 2019), la loro partecipazione e i contributi sono stati essenziali nella formazione di musiche nazionali, inclusa la cueca (la danza nazionale).
La cueca è un genere sincretico di origine criolla che risale alla zamacueca peruviana, un ceppo che incorpora elementi africani, rivelando un’ipocrisia storica nella costruzione dell’identità culturale.
Le Tradizioni Regionali: Il Mosaico Sonoro Cileno
La musica cilena si articola in distinte espressioni regionali, come l’Influenza Germanica a Sud, dove l’accordion si integrò rapidamente nella musica chilota di Chiloé, e la Musica Andina Settentrionale, che condivide tradizioni con l’Altiplano, come la Diablada, una danza che mescola simbologia indigena e cattolica.
Radici: folclore tradizionale cileno e canto a lo poeta
Il folclore cileno rurale è dominato dalla complessa interazione tra poesia orale e maestria strumentale, esemplificata dal Canto a lo poeta e dal guitarrón chileno.
Il Canto a lo Poeta e la Tradizione Orale: Temi, Filosofia e Funzione Sociale
Il Canto a lo poeta è una tradizione orale profondamente radicata, particolarmente viva in zone come Pirque. È una pratica che incarna la saggezza popolare, spesso trattando temi filosofici, religiosi, lirici o politici. La sua persistenza come tradizione puramente orale, evitando le “convenzioni metodologiche” della musica occidentale, è considerata l’energia stessa che la mantiene viva.
Analisi Tecnica: La Décima Espinela e il Verso Ottosillabico
La struttura poetica del Canto a lo poeta è quasi universalmente basata sulla décima, nota anche come décima espinela. La décima è caratterizzata da stanze di dieci versi, ciascuno composto da otto sillabe, con lo schema di rima rigoroso ABBAACCDDC. La décima è spesso improvvisata dai decimistas o decimeros, specialmente in duelli poetici noti come payadas.
Abbiamo esplorato le fondamenta del suono cileno, dal potere cosmologico del newen Mapuche alla sofisticata poesia del Canto a lo poeta. Ma la vera rivoluzione culturale e politica del Cile, che ha risuonato in tutto il mondo, stava per arrivare.
La storia di come la musica sia diventata un’arma di resistenza, un simbolo globale di lotta e un mezzo per superare la repressione, è riservata ai nostri abbonati Sing Plus.
Per abbonati a SIING PLUS
Continua a leggere scaricando la dispensa completa per scoprire il ruolo di Violeta Parra, il martirio di Víctor Jara, e l’esplosiva fusione della Nueva Cumbia Chilena nell’era moderna.
ACCEDI AL MATERIALE ESCLUSIVO SIING PLUS
OPPURE SOSTIENICI
👉 ABBONATI A SIING PLUS CON UNO SCONTO ESCLUSIVO
Leggi anche l’articolo: Pronti con la voce? Il libro scritto da Elisabetta Rosa